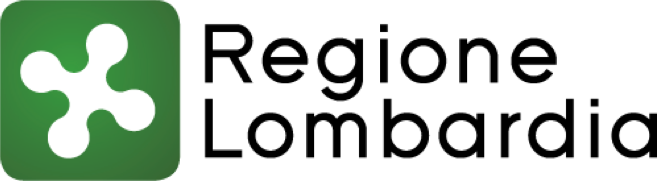Nodo - I lavoratori frontalieri
Società
I lavoratori frontalieri
attraverso il reportage di Cristina Omenetto (1995)
Progetto: Confini
Per “frontalierato” si intende il fenomeno di pendolarismo lavorativo lungo il confine tra due nazioni limitrofe; rispetto al lavoratore migrante, il frontaliere mantiene la residenza e l’abitazione nel paese di provenienza mentre la sua occupazione si svolge in un paese diverso. La regolamentazione fiscale e nei diritti sociali di questi lavoratori è oggetto di complesse convenzioni bilaterali tra i paesi confinanti e la stessa Unione Europea ha cercato di sbrogliare la matassa della regolamentazione in particolare in campo fiscale e di sicurezza sociale, riguardante il lavoro transfrontaliero dal momento che, anche tra i paesi facenti parte l’UE, manca una definizione uniforme del lavoro frontaliero. Se ancora oggi dunque la posizione del lavoratore frontaliero di presenta giuridicamente complessa, si consideri che la Svizzera, estranea alle politiche e ai tentativi di sintesi e accordi tra stati della UE, accoglie bel oltre la metà dei lavoratori frontalieri presenti in Europa (circa 320.000 persone; Cfr. fonte). Secondo l’ultimo rilevamento statistico riportato sul sito governativo della Confederazione elvetica, nel 2017 i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera erano oltre 73.000 (nel 1995 erano circa 36.000). Spesso quella di affrontare il frontalierato è stato, nel corso della storia, un’alternativa ad una scelta di emigrazione per lavoratori impiegati soprattutto nei cantieri edili e nell’industria; oggi però i lavoratori italiani sono occupati in tutti i settori dell’economia elvetica e sono spesso professionisti specializzati. In modo tanto scontato quanto inevitabile la forte presenza, soprattutto in certe aree, di lavoratori frontalieri pur necessari all’economia e allo sviluppo dell’economia terziaria rivolta all’innovazione della nazione ospitante, ha originato un aspro malcontento alimentando la retorica xenofoba dei partiti populisti locali. “Il frontaliere è un capro espiatorio ideale: è presente in Svizzera senza esserlo davvero e si fatica a inquadrarlo concretamente”, spiega Claudio Bolzman, professore dell’Alta scuola di lavoro sociale di Ginevra (cfr. fonte). Fu in questo clima politico che, mentre in Europa si cercava di abbattere i muri e le frontiere tra le nazioni, il referendum Svizzero del 9 febbraio 2014 decise di limitare la libera circolazione dei cittadini europei oltre i confini nazionali. Se questa è, attualmente, la condizione che si trovano ad affrontare lavoratori, anche di alta specializzazione e pur integrati nel tessuto sociale e lavorativo svizzero, è facile immaginare quali dovessero essere le condizioni di lavoro e sociali di coloro che hanno percorso nei decenni e secoli passati questa stessa via avanti e dietro la linea di confine. La fotografa Cristina Omenetto ha dedicato, nel 1995, un servizio fotografico ad illustrare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori frontalieri nelle località sulla frontiera tra la Svizzera (CH) e l'Italia (I), Marchirolo (VA), Lamone (vicino a Lugano, CH), Savosa (vicino a Lugano, CH), Ronago (CO). Nata a Milano nel 1842, si è avvicinata alla fotografia negli anni Ottanta dopo diverse esperienze di lavoro e studio all’estero appassionandosi prevalentemente ai temi dell’indagine sociale e all’estetica del ritratto e del paesaggio rispetto al quale manifesta uno stile personalissimo impegnandosi in tecniche sperimentali. Tra gli anni ’80 e gli anni ‘90 ha pubblicato diversi libri fotografici sulle tematiche dell’immigrazione; ha collaborato con l’Archivio di Etnografia e Storia sociale per il quale realizza diversi progetti fotografici; le sue opere sono esposte in collezioni pubbliche e private.
FotografiaConfiniSvizzeraLavoratori frontalieriPendolarismoDocumenti attualmente selezionati per il progetto
Non sono presenti contenuti.